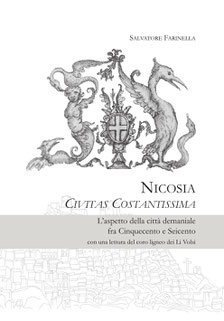La civiltà contadina fra storia e tradizione: il ciclo del grano
di Salvatore Farinella©, testo inedito tratto da Gangi. Il tempo della spiga. Tradizioni e memorie della civiltà contadina e della vita quotidiana nel borgo madonita. Abitudini, saperi, costumi, tradizioni popolari e gastronomiche, eredità materiali e immateriali fra Ottocento e Novecento (in corso di lavorazione)

‘A mititìna (metà giugno-inizio luglio)
Come la semina, ‘a mititìna (mietitura) rappresentava la tappa più importante del ciclo del grano e impegnava sei-otto mititùra (mietitori) e uno o due ligatùra (legatori) per ogni campo di grano. Era un momento particolarmente intenso di lavoro e doveva essere fatto quando le spighe erano ‘ngranàti (mature al punto giusto): perciò l’inizio della mietitura variava da contrada a contrada, prima ‘na marìna, ossia in quelle parti del territorio più basse (fra i cinque e i settecento metri di altitudine, per esempio Bordonaro Sottano e Soprano, Rolìca, Regiovanni, Mandralisca), qualche settimana dopo nelle parti più alte (fra i settecento e i novecento metri), e si andava avanti per diverse settimane (dai quindici ai venti giorni).
I mititùra erano in genere jurnatàra o misalùri (lavoratori a giornata o a mese) e frequentemente provenivano da altri paesi. Ancora prima dell’alba, intorno alle quattro del mattino, essi erano già all’àntu - ossia al punto d’inizio, sotto vento per evitare che le spighe curvate andassero a finire sul volto dei mietitori danneggiando i loro occhi -, dopo essersi preparati adeguatamente: sopra la camicia e i pantaloni veniva indossato ‘u fadàli o pitturàli, un lungo grembiule di cuoio ma per lo più d’alòna (tela olona) per proteggere le gambe e il petto sia da eventuali colpi maldestri che dalle rèsche, le punte delle spighe tagliate che divenivano particolarmente pericolose: nell’avanbraccio sinistro veniva indossato ‘u vrazzàli, una manica in cuoio o in tela grezza che aveva le medesime funzioni di protezione dai colpi di falce e dallo strusciare delle spighe.
Completavano ‘u vistimìntu (la vestizione) ‘i jitàli di canna (i ditali) indossati al medio, all’anulare e al mignolo della mano sinistra al fine di proteggere queste dita - le più esposte - dai colpi taglienti della fal-ce. Nella mano destra veniva impugnata ‘a fàci o ‘u facigliùni (la falce semplice o quella più grande), dalla lama sottile ricurva, dentata e a punta, e l’impugnatura di legno. In testa infine, per proteggersi dal sole, un largo cappello di paglia, una cùppula o più semplicemente un fazzoletto con le quattro punte annodate.
Anche ‘u ligatùri era protetto dal pitturàli e alla cintola portava diversi mazzi di lijàmi: nella mano destra teneva l’ancìnu, un grosso uncino di ferro col manico in legno che gli permetteva di raccogliere ‘i jìrmiti, i fasci di spighe mietuti e allineati per terra, mentre nella sinistra reggeva l’ancinèdda, una forcella di legno con i bracci lunghi circa sessanta centimetri che serviva per sollevare agevolmente ‘i jìrmiti.
Alle prime luci dell’alba ‘i mititùra, e dietro di loro ‘i ligatùra che avevano designato il punto d’inizio, erano pronti a mètiri ‘u lavùru: segnatisi col segno della croce, e alle parole du ligatùri “E ladàmu e ringrazijàmu ogni momèntu lu Santìssimu e Divinìssimu Sacramìntu” alle quali ‘i mititùra rispondevano “Sèmpri sìja ladàtu”, si dava il primo colpo di falce mormorando “In nòmi di Dìja”.
Posizionati a una certa distanza l’uno dall’altro, i mititùra afferravano
Man mano che si andava avanti lungo ‘i filàri, ‘u ligatùri che seguiva ccu l’ancìnu andava raccogliendo ‘i jìrmiti allineati, incastrandone sei ni’ l’ancinèdda: quindi ‘u ligatùri estraeva ‘na lijàma e vi stendeva sopra da otto a dieci jìrmiti e, aiutandosi col ginocchio, le comprimeva e ‘i ‘nfasciàva, ossia li legava assieme formando ‘a grègna (covone): venti grègne (tante quanto un màzzu di lijàmi) formavano un màzzu di grègni.
Di tanto in tanto era necessario sospende il lavoro per qualche minuto per asciugarsi il sudore e per bere un sorso d’acqua dùnni ‘u bùmmulu o un mùccuni di vinu dùnni ‘u jàscu: poi si ritornava al lavoro fino alla pausa del pranzo, per riprendere per tutto il pomeriggio. Alla fine da’ jurnàta ‘i grègni si ammassavano a gruppi di quattro per facilitare il successivo carico e il trasporto all’aia, dopo una settimana di stagionatura. Al tramonto, esausti, ‘i mititùra facevano ritorno ‘e càsi oppure o’ bàgliu du barùni per cenare e riposare: al mattino, prima dell’alba, ricominciava un’altra giornata di mètiri e ligàri.
Diversi documenti d’archivio attestano come quelli di mètiri e ligàri fossero dei lavori antichi, rimasti tali e quali nella tradizione gangitana (e siciliana) fino alla metà del Novecento. A titolo di esempio riportiamo un atto del 29 novembre 1728 col quale ben 23 persone di Gangi - Stefanus Sabella Capuralis, Petrus Sabella, Joseph Sabella, Jo(hann)es Sabella, Thomas Dongarrà, Gandolfus lo Ciuro, Cataldus lo Conti, Fran(cis)cus Spitali, Joseph Vazzano, Franciscus de Vinuta, Joseph Carmusciano, Nicolaus de Angelo, Sanctus de Blando, Gandolfus Millitarì, Vencturus lo Manto, Vincentius Ristivo alias Taccio, Carminus Vazzano, Ignatius Patirnò, Cataldus Saragusa, Leonardus de Blando, Silvestrus de Blando, Silvestrus de Angelo, Franciscus de Blando Cavallazzo - si obbligavano con don Fran(cis)co li Destri a «metere e lighare tutti li seminati d’orgio e lavore nelli feghi di Terrati ed Alborchia allo staglio alla tunna, con darci d(ett)o di li Destri Aceto, Aglie e Cipulla gratis ed una persona per portari acqua e leghami a posto», il tutto per una mercede «conforma la stagliata del d(otto)r d(on) Giacomo di Miceli e del R(everen)do Sac(erdo)te d(on) And(re)a Bongiorno … unciam duodecim et t(areno)rum q(uat)uordecim»: oltre a ciò il li Destri avrebbe dovuto dare ai mietitori «tutta la farina e vino necessarij per metere e lighare d(et)ti lavori ed orgio cioè la farina alli prezzi correnti ed il vino a t(arì) tre e gr(ana) quattro la lancella» (10).

‘A stravulijàta
Alla fine della mietitura, dopo circa una settimana durante la quale ‘i grègni ammassati al sole avevano avuto modo di asciugarsi, si provvedeva alla stravulijàta, ossia al trasporto du’ lavùru mitùtu ‘nta l’àrija per la successiva trebbiatura: a volte, soprattutto ne’ fì’udi, la distanza da percorrere era considerevole.
Il trasporto dei covoni, che si svolgeva di solito all’alba o al tramonto per evitare che le spighe si seccassero troppo e che si rompessero durante il tragitto, poteva avvenire in due modi. Uno prevedeva lo spostamento con gli animali da soma, i muli o gli asini: in questo caso si utilizzavano 'i siddùna, sorta di sostegni ricurvi in legno sistemati ai due lati da vardèdda (basto) e assicurati da una cìgna (cinghia) ai quali venivano assicurati tre o quattro grègne per lato con una robusta corda di canapa. In mancanza di’ siddùna il carico veniva sistemato ‘a nàca (a culla) ai fianchi delle bestie tramite le sole corde. ‘U vurdunàru (bordonaro) conduceva ‘a rìtina (retina) di 7 o 9 muli bardati e legati uno dietro l’altro, mentre egli stava a cavallo della prima mula capu rìtina.
L’altro modo di trasportare ‘i grègni prevedeva l’uso da’ stràvula, un mezzo di trasporto in legno trainato da due buoi aggiogati e dotato di due lunghi “pattini” chiamati currìnti che consentivano di scivolare agevolmente sul terreno e sulle stoppie: sul piano della stràvula venivano accatastate ‘i grègni per essere trasportate a destinazione. In genere occorrevano diversi viaggi - sia di bestie che di stràvuli - per completare il trasporto di tutti i covoni all’aia.
‘A stràvula era un mezzo di trasporto molto antico, forse risalente al tempo della Sicilia indigena. Un documento dell’11 marzo 1620 attesta per esempio la vendita, da parte del m(agiste)r giulianus de randaczo (probabilmente un falegname) all’ar(ti)s me(dicin)e doc(tori)s J(ohanni)s ph(ilipp)o vitali, di «duas stragulas bone lingnaminis bene fattam» per il prezzo di 1 onza (11): un altro documento del 9 maggio 1666 riguarda invece un contratto per «pisari e straguliare» (12), a testimonianza di come anche i termini in uso fino alla metà del Novecento abbiano radici molto antiche.

‘I spicalòra
Alla fine da’ mitùta e da’ stravulijàta le campagne si riempivano di donne e bambini - a volte provenienti anche da paesi lontani - i quali, spinti dall’indigenza ripassavano i campi raccattando le spighe cadute o dimenticate: erano ‘i spicalòra, le spigolatrici. Ccu ‘na ‘mmèsta (sacchetto di tela) appesa alla vita o con grandi fadàli (grembiuli), donne e ragazzini si davano un gran da fare per racimolare le spighe lasciate dietro dai mititùra: riempiti sacchetti e grembiuli esse le riversavano in sacchi più grandi, pressandole perché ne contenessero una quantità maggiore.
Dopo una pausa per prendere un muzzicùni, il lavoro di raccolta delle spighe continuava fino quasi al tramonto: poi si riprendeva la strada di casa. Se ‘i spicalòra venivano ingaggiate dal barone, a fine giornata una parte delle spighe raccolte doveva essere consegnata al padrone: nel caso in cui erano autonome riuscivano invece a portare a casa tutto quanto avevano raccolto.
Il mattino seguente, di buon ora, le spighe venivano distese su un telo posto sul pavimento e venivano battute cca màzza di lìgnu (mazza di legno), fino a che i chicchi di grano uscivano dalle spighe: quindi venivano puliti dalla χiùsca (pagliuzza corta mista a polvere) e riposti nella còffa. Chi aveva in casa un mulinìddu di pètra (un mulinello in pietra) provvedeva a macinare il grano e a ottenere la farina, gli altri erano costretti a portare il prodotto al mulino ‘o χiùmi (al fiume), col rischio di vedersi ridimensionata la quantità di farina ottenuta.
Note
10 - ASCG, Fondo notai defunti, notaio Antonio li Destri, vol. XV 1-11, cc. 191v-192v.
11 - Ivi, notaio Egidio di Salvo, vol. IF5, cc. 109v-110.
12 - Ivi, notaio Giovanni di Salvo, vol. IVF3, c.s.n.
 Gangi
Studi e ricerche storiche
di Salvatore Farinella
Gangi
Studi e ricerche storiche
di Salvatore Farinella