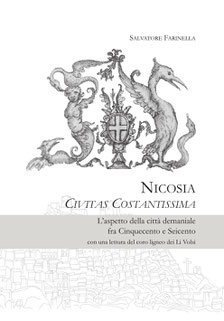La civiltà contadina fra storia e tradizione: il ciclo del grano
di Salvatore Farinella©, testo inedito tratto da Gangi. Il tempo della spiga. Tradizioni e memorie della civiltà contadina e della vita quotidiana nel borgo madonita. Abitudini, saperi, costumi, tradizioni popolari e gastronomiche, eredità materiali e immateriali fra Ottocento e Novecento (in corso di lavorazione)
‘I majìsi
Poiché il grano è una coltura che sfrutta il terreno, fin dall’antichità ci si accorse che esso doveva essere coltivato in rotazione con altre colture dette “da rinnovo”: perciò si cominciò ad avvicendare le colture con ciclicità biennale, triennale o quadriennale lasciando il terreno a riposo senza essere seminato per un anno, ossia a maggèse.
‘I majìsi sono ampiamente documentati a Gangi fin dal XVII secolo, ma la pratica era sicuramente in uso nei secoli precedenti. Nell’ottobre del 1690 per esempio un affittatore di terre si impegnava a lavorare il terreno «per seminare tanto li maisi quanto li infrascritti restucci», mentre il locatore si impegnava a «darci la semenza necessaria per seminare d(ict)i maijsi et d(ict)e ristucci in tanto frum(en)to bono posto nella grutta di d(icto) fego» (6): in un altro contratto dello stesso periodo si specificava che per il maggese si dovevano «siminari in d(ict)i terri nell’anno p(rese)nte tumina una et dui di favi et una di ciciri» (7). Preparare un terreno a maggese si diceva ammaijsàri e majisàru era colui che preparava il terreno, termine quest’ultimo divenuto ‘ngiuria di alcune famiglie gangitane (8).
Nella tradizione contadina gangitana fra Ottocento e Novecento fàri ‘i majìsi, per quei terreni che avevano prodotto foraggio e che dovevano essere seminati a grano, significava preparare il terreno con una aratura preliminare nei primi giorni di settembre.
Alla fine dell'Ottocento «il prezzo di una giornata di aratro varia molto da luogo a luogo e secondo la stagione; oscilla tra le 6 e le 14 lire; ordinariamente è di 8 lire per lavoro di maggese, di 10 a 12 per la sementa» (9).

L’aratura (settembre e fine ottobre)
Il ciclo del grano vero e proprio iniziava con l’aratura, dopo che a fine agosto si era provveduto ‘a brusciàri ‘i ristùcci (bruciare le stoppie): dalla metà di settembre si provvedeva ad aràri ma di nuovo verso la fine di ottobre si passàva ‘u tirrènu - si rifunnìva - per renderlo ancora più idoneo alla semina.
La sera prima del giorno stabilito per l’aratura veniva preparato e controllato tutto l’occorrente, l’aràtru (l’aratro), ‘u jùvu (il giogo), ‘i vìrtuli (le bertole), ‘a sacchìna (piccolo sacco di tela per dare da mangiare ai muli) e 'a sacchìna che avrebbe contenuto ‘u pàni e ‘u cubbanàggiu (il pane e il companatico), ‘i vìstii (le bestie, vacche o muli): la levata avveniva ancora prima dell’alba, circa alle quattro del mattino, e dopo aver sistemato il tutto ci si avviava all’àntu (verso il campo da arare) con le cavalcature e gli animali da aggiogare.
Giunti al campo sul fare dell’alba si ‘mpaijàvanu ‘i vàcchi (si appaiavano le vacche) o ‘i vìtij (i muli) collegando ‘a pìrtica di l’aràtru (la pertica dell’aratro) ‘o jùvu (al giogo): l’aratro, in legno e ca vòmmira (vomere) in ferro, era del tipo ‘a chiùvu (a chiodo), antichissimo e conosciuto fino dalla preistoria.
‘Mpaijàti l’armàli (le vacche) o ‘i vìstij (i muli), ‘u viddànu si segnava col segno della croce e cominciava a tracciare il primo solco tenendo l’aratro ppa manuvèdda (manico) e guidando gli animali ccu capìzzu (redini): si iniziava a fare i solchi dalla finàjta (dal confine), per tracciare il perimetro dal campo da arare, e si proseguiva in diagonale con solchi paralleli della profondità di 25-30 centimetri.
Il lavoro proseguiva per l’intera giornata, fino al tramonto: tuttavia ci si concedeva delle pause per prendere un muzzicùni e per fare riposare gli animali, intorno alle nove per la colazione intorno a mezzogiorno per il pranzo. Seduti all’ombra di un albero e appoggiati ‘nte vardèddi (selle), dopo aver provveduto a dare agli animali ‘a pruvènna di fàfi sìcchi (pasto di fave secche) preparata ‘nte sacchìni, si estraeva dùnni ‘i vìrtuli ‘a guastèdda di pàni, gnè tumàzzu, du’ alìvi, ‘na cipuddètta (la forma di pane, un po’ di formaggio, due olive, una cipolletta) e si consumava il pasto: di tanto in tanto ‘un muccùni di vìnu dùnni ‘u jàscu (un boccone di vino dal fiasco) o ‘na sursàta d’acqua dùnni ‘u bùmmulu (un sorso d’acqua dal piccolo contenitore in terracotta) rinfrancava e aiutava a ingoiare quei bocconi asciutti.
Subito si riprendeva il lavoro continuando a solcare il terreno fino al tramontare del sole. L’aratura continuava per tutto il mese di settembre e per i primi giorni di ottobre, aspettando con trepidazione i giorni della semina e sperando in condizioni atmosferiche favorevoli (né troppa pioggia, né troppo arido): verso la fine di ottobre si passàva ‘u tirrènu con una seconda aratura, dandogli una rifunnùta, ossia arando perpendicolarmente ai solchi già tracciati, rompendo le zolle più grosse e rimuo-vendo l’erba rimasta tra i solchi. Quindi si lasciava riposare il terreno per qualche settimana.

‘I simìnti (novembre, febbraio/marzo)
Alla fine di ottobre il grano da seminare veniva preparato depurandolo dalle impurità (pietruzze, semi estranei, polvere), cioè si preparava ‘a simènta ammannàta: era un lavoro fatto dalle donne e dai bambini, tutti intenti a ripulire ‘a simènta distesa sul tavolo o ‘nta maìdda o cirnùta ccu crìvu (passata al vaglio). Dopo essere stata preparata ‘a simènta veniva messa ‘nta còffa, una cesta a corpo tronco conico intrecciata con foglie di tifa o di palma nana, con due manici laterali e una cordina per essere messa a tracolla.
Nell’antichità la semina rievocava il mito di Kore-Proserpina che, secondo il volere di Zeus, era costretta a trascorrere i quattro mesi invernali (o sei mesi, secondo altre fonti) sottoterra in compagnia del suo sposo Ade, fratello dello stesso Zeus e signore degli inferi.
La semina - che si svolgeva nella fase della luna calante ed entro il primo quarto di luna nuova - impegnava quasi tutto il mese di novembre fino ‘o Muntisirràtu, la festa della Madonna del Monserràto il 21 novembre: in quel giorno tutte le attività lavorative dovevano cessare per poi riprendere regolarmente. A volte, quando l’aratura veniva ritardata a causa delle piogge autunnali, la semina poteva essere fatta fra febbraio e marzo, seminando in quel caso ‘a tumminìja che con la sua crescita anticipata consentiva di avere il raccolto per tempo.
Le tecniche per la semina erano due, ‘a sùrcu (a solco) o ‘a spàgliu (a pioggia): in ogni caso, prima di iniziare, ci si segnava col segno della croce. La prima tecnica prevedeva che ‘u siminatùri (il seminatore) - che doveva essere esperto nello spargere il grano in maniera uniforme -, dopo aver preso un pugno di semi dalla còffa tenuta a tracolla, facesse cadere il grano direttamente dentro il solco tracciato dall’aratore che lo precedeva di alcuni passi: i chicchi scorrevano tra il pollice e l’indice socchiusi e venivano indirizzati in maniera tale che fossero ben distanziati per evitare l’affollamento delle piantine.
Il metodo ‘a spàgliu o ‘a pruvìnu, più utilizzato, consisteva invece nel prendere un pugno di grano dalla còffa e nel lanciare i chicchi facendoli uscire fra il pollice e l’indice semichiusi seguendo un movimento a semicerchio o a ventaglio, prima da un lato e poi dall’altro, seguendo l’aratore che nel frattempo aveva provveduto a tracciare dei solchi paralleli formando una striscia di terreno larga da quatto a sei metri per evitare di spargere il seme due volte nello stesso posto: l’abilità du siminatùri consisteva nel dosare la quantità i grano nel pugno e nello spargere i semi in maniera uniforme su tutto il terreno.
In entrambi i metodi, dopo avere sparso ‘a simènta i solchi venivano ricoperti per evitare che i chicchi venissero beccati dagli uccelli: ‘nu zappatùri seguiva l’aratore e il seminatore spianando i solchi, in seguito sostituito dall’èrfici (erpice) formato da una intelaiatura di legno o di ferro a cui erano agganciati una serie di denti in file parallele che, fatti scorrere sul terreno con l’ausilio delle bestie ‘mpaiàti, coprivano i solchi fra un passaggio e l’altro.
La quantità di semente necessaria per seminare un tùmminu di terreno (a Gangi 2.143,59 metri quadrati) era di circa 2,5 tùmmina (circa 40 chilogrammi considerando che 1 tùmminu era pari a chilogrammi 15,868).

‘A zappulijàta e ‘a sciarbatùra (marzo/aprile)
Quando le piantine di grano erano ormai germogliate e avevano raggiunto un’altezza di circa dieci centimetri occorreva ritornare sul campo allo scopo di ripulire il grano dalle erbe infestanti che erano cresciute insieme ‘o lavùru (il frumento): alle prime luci dell’alba, nel mese di marzo, ci si recava quindi all’àntu e, dopo i preliminari, ci si disponeva a gambe divaricate sopra un filàru di lavùru (filare di frumento) e, armati di zappùni e zappùdda (zappe con lame di diversa larghezza) e di rasòla (raschietto in ferro) legato con una cordicella alla cintola, dopo aver dato uno sputo alle mani callose e averle sfregate, si iniziava l’attento lavoro di pulitura.
‘A zappulijàta du lavùru (sarchiatura del frumento) era operazione delicata e andava eseguita con molta attenzione: era importante infatti smuovere il terreno sui due lati du’ filàru evitando di recidere le piantine e, al tempo stesso, estirpare le erbe infestanti: si andava avanti fino alle nove, quando si prendeva un muzzicùni, e poi ancora fino a mezzogiorno quando ci si fermava per pranzare all’ombra di un pèdi d’àrvulu (piede di albero). Poi si ritornava a zappulijàri fino al tramonto quando i faceva ritorno a casa.
Nel mese di aprile, ma anche nei primi di maggio, si provvedeva ancora a ripulire il grano un’ultima volta prima della mietitura: si eseguiva cioè ‘a sciarbatùra (scerbatura), un lavoro altrettanto delicato e difficoltoso perché non era semplice riconoscere ‘nmìnzu ‘o lavùru (in mezzo al frumento) le erbe infestanti. Col grano oramai abbastanza alto era difficile utilizzare ‘a zappùdda e perciò si scurrìja l’èrva (si scorreva l’erba) estirpandola con le mani: occorreva quindi un buon occhio e una grande esperienza per poter estirpare le piante infestanti senza danneggiare il frumento. Il lavoro di sciarbatùra poteva durare diversi giorni, ma anche qualche settimana: fra le erbacce d estirpare c’era ‘u giògliu e ‘a jìna (simile all’avena) non facilmente distinguibili dal frumento per via della loro somiglianza: l’erba così estirpata veniva ammassata ai bordi del campo per essere usata come foraggio per gli animali.
Nel mese di aprile venivano raccolti ‘i lijàmi di ddìsa (10), i fili di corda vegetale che servivano per legare insieme i fasci di spighe: ‘i lijàmi si raccoglievano mietendoli ccu facigliùni (falce più robusta) e si preparavano ‘a màzzu di venti lijàmi ognuno.
Note
6 - ASCG, Fondo notai defunti, contratto del 1 ottobre 1690, notaio Antonio li Destri, vol. XV 1-1, c. 70.
7- Ivi, c. 75.
8 - Cfr. S. Farinella, Di cu cci dìcinu. Cognomi e 'ngiurie a Gangi dal XIV al XX secolo, Madonnuzza-Petralia Soprana 2008.
9 - L. Franchetti, S. Sonnino, La Sicilia nel 1876, Firenze 1877, ristampe Firenze, Vallecchi, 1925 “Collezione di studi meridionali” e Firenze 1974 “Saggi Vallecchi”, in particolare il volume II, curato da Sidney Sonnino, I contadini in Sicilia, parte I, cap. 2, pp. 180-181. L’autore si rifà dichiaratamente ai testi G. Caruso, Studi sulla industria dei cereali in Sicilia e le popolazioni che la esercitano, Palermo, 1870 e P. Cattani, Sulla Economia agraria praticata in Sicilia; nozioni, costumi e usi della sua grande agricoltura, Palermo 1873.
 Gangi
Studi e ricerche storiche
di Salvatore Farinella
Gangi
Studi e ricerche storiche
di Salvatore Farinella